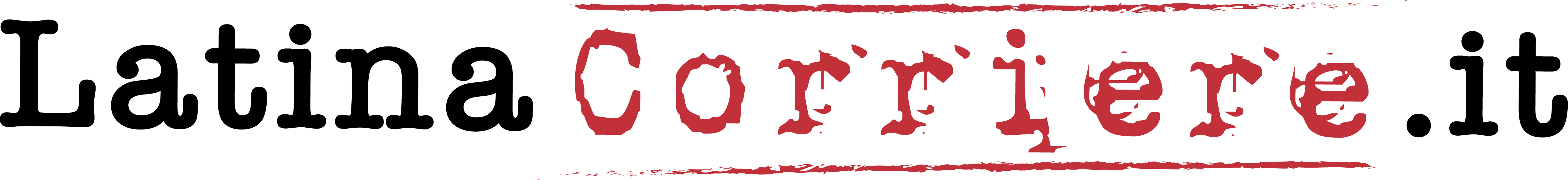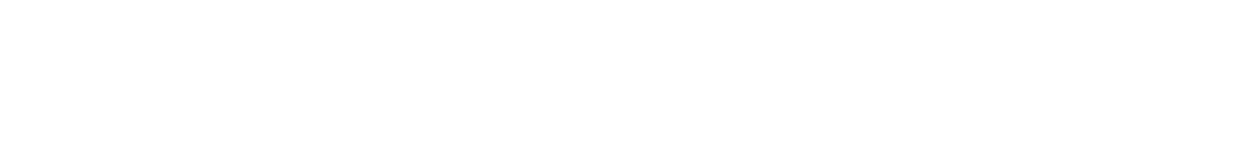“A Latina comandiamo noi, noi di Campo Boario: io, Armando e i figli”. E’ questa una delle tante frasi che Agostino Riccardo, arrestato martedì scorso nell’ambito dell’operazione Alba Pontina, avrebbe rivolto alle vittime delle estorsioni organizzate e gestite dal clan Di Silvio. Nella corposa ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Antonella Minunni su richiesta della Dda di Roma a carico di 25 persone, sette delle quali finite in carcere con l’aggravante del vincolo associativo con utilizzo del metodo mafioso, viene evidenziata la presunta responsabilità degli indagati su una lunga serie di delitti dove le estorsioni risultano in gran numero superiori alle altre tipologie di reato.
La posizione di Agostino Riccardo viene collocata dagli inquirenti nel gruppo di comando del sodalizio mafioso “autoctono” operante a Latina e capeggiato da Armando Di Silvio. Sarebbe stato lui a individuare le vittime, commercianti, imprenditori e finanche professionisti, da sottoporre ad estorsione, pianificando le modalità di intimidazione con i figli del capo clan ed operando in prima persona. Sarebbe stato lui ad operare anche in situazioni di “recupero crediti” per conto di terzi che, proprio per la nomea del clan e della capacità di incutere terrore, si sarebbero rivolti ai Di Silvio nella speranza di incassare la pretesa anche se consapevoli di dover “pagare” per il servizio. Nella speranza, appunto, perché alla fine della fiera, come spiegato dal dirigente della Squadra Mobile di Latina Carmine Mosca in occasione della conferenza stampa indetta subito dopo gli arresti, nessuno dei terzi sarebbe riuscito a recuperare il credito.
Tra le tante estorsioni perpetrate c’è quella ai danni di due cognati, che chiameremo utilizzando nomi di fantasia: Mario Rossi e Paolo Bianchi. Una storia che si avvolge attorno al malaffare di vittime e carnefici. E’ la sera del 31 agosto 2016 quando Bianchi si presenta in Questura per denunciare quanto capitatogli nel pomeriggio dello stesso giorno. Bianchi, che in quel periodo abitava nella casa della compagna di Rossi, suo cognato appunto, riferisce che alle 15 qualcuno aveva suonato alla porta: tre uomini che chiedevano di Rossi, che in quel momento non era presente, e che pretendevano la restituzione di circa 200mila euro per conto di una donna. Se ne andranno via soltanto dopo aver parlato al telefono con il “debitore” Rossi e aver messo a soqquadro l’abitazione, con in mano 800 euro consegnate dallo stesso Bianchi. Solo l’inizio dell’incubo.
Anche Rossi si rivolgerà alla Polizia, dopo un mese e mezzo dall’irruzione nell’abitazione della sua compagna, abitata da Bianchi. Nel frattempo, la Squadra Mobile aveva già identificato i tre aguzzini nelle persone di Riccardo, Samuele e Gian Luca Di Silvio, grazie all’acquisizione nell’imminenza del fatto delle immagini delle telecamere di video-sorveglianza installate nel palazzo. Rossi, dicevamo, si presenterà in Questura il 18 ottobre 2016 per denunciare che quattro giorni prima era stato avvicinato da Riccardo, che già conosceva; se lo era trovato nell’androne del palazzo e lui non si era sottratto al “chiarimento”, conclusosi con pesantissime minacce. Riccardo – secondo quanto riferito in Questura da Rossi – avrebbe detto alla sua vittima di turno di essere già andato nel suo studio con l’intenzione di sparargli e dall’androne del palazzo se ne era andato via con la seguente minaccia: “Stanotte uccidiamo te e le tue bambine”. Quanto basta per spingere Rossi a formalizzare la denuncia, pur consapevole di dover fornire non poche spiegazioni.
La donna creditrice: Rossi spiega che era stata una sua cliente e che nell’ambito di un più ampio contenzioso aveva stipulato una transazione con cessione di credito in suo favore. Nell’ordinanza di custodia cautelare, tuttavia, si evidenzia che la somma era stata incassata da Rossi, come già accertato dalla Guardia di Finanza, in maniera illegittima.
In un susseguirsi di dichiarazioni, Rossi riferisce che Riccardo gli aveva detto che loro, quelli dei Di Silvio, avevano più armi della Questura, e che avevano copertura: “Non lo vedi? Siamo tre mesi che siamo venuti a casa tua e siamo ancora qua”.
Un fiume in piena Rossi che riferisce agli investigatori di aver conosciuto Samuele Di Silvio e suo padre Armando, detto Lallà, nel 2013 quando a seguito di un’ordinanza cautelare era stato ristretto nel carcere di Rebibbia dove si trovavano detenuti per altre ragioni padre e figlio e di aver subito alcune pressioni anche in quella sede, avendo a pretesa la consegna della sua fede nunziale con brillanti. Rossi riferisce anche che, nel mentre era in carcere, la moglie di Armando si sarebbe recata dalla sua compagna pretendendo la somma di 10mila euro in cambio di una sua più veloce scarcerazione.
In questa brutta pagina di cronaca molti i dettagli inquietanti tesi a dimostrare l’elevata capacità intimidatoria del gruppo. Nel luogo in cui ha inizio l’estorsione, il trio avrebbe riferito a Bianchi che la donna creditrice si era rivolta a dei calabresi pronti a sparare. La minaccia di uccidere le figlie di Rossi o di andare nello studio a sparare a lui è accompagnato dalla presenza di auto “sospette” attorno ai luoghi frequentati dalle vittime o dall’avvicinamento ai parenti più prossimi delle stesse.
Nelle sue rivelazioni, il pentito Renato Pugliese, sull’estorsione ai danni a Rossi e Bianchi, riferirà agli inquirenti – ad aprile 2017 – che gli autori avrebbero incontrato presso il bar Cifra il figlio di Rossi allo scopo di convincerlo a ritirare la denuncia.