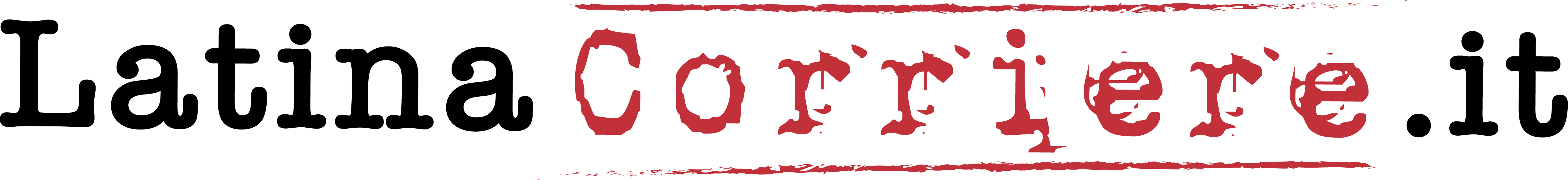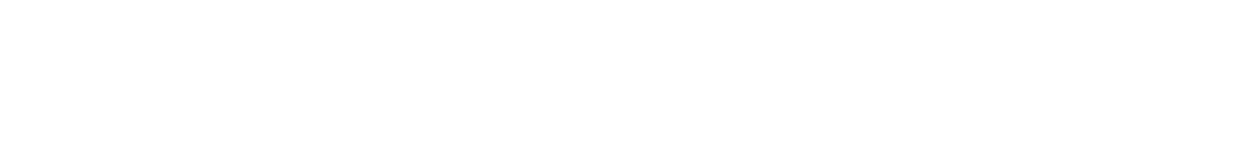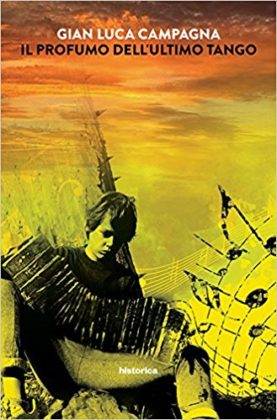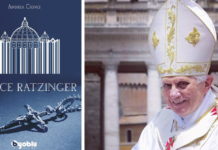Calcio e potere, dittatura e coscienze sottomesse, vendetta e perdono. Eccoli alcuni dei temi affrontati da Gian Luca Campagna, giornalista e scrittore di Latina, nel suo romanzo ‘Il profumo dell’ultimo tango’ (Historica, 350 pp, euro 18). Siamo in Argentina, durante i Mondiali del 1978, quelli chiamati della vergogna, quelli dei desaparecidos, della junta militar, le Madres e le Abuelas de plaza de Mayo: un tema mai superato e dalla difficile risoluzione. Campagna ci prova e forse c’è anche riuscito, considerata la prossima traduzione in spagnolo del romanzo. Intanto, sabato 24 agosto nella piazza principale di Sabaudia, alle 21, la presentazione non segue le tracce canoniche, c’è la fisarmonica d’eccezione del maestro Marco Lo Russo, l’esibizione dei tangueros e la lettura recitata di alcuni attori.
“Fondere i linguaggi artistici è segno di elasticità mentale, apertura al confronto senza timori e una chiara predisposizione a scoprire altri orizzonti multidisciplinari. Però per diritto di primogenitura va detto che è stato il fisarmonicista Marco Lo Russo a contattarmi per propormi una fusione del linguaggio narrativo con quello musicale. Penso che lo abbia convinto a intraprendere questo percorso per la forza e il fascino che il tango emana. Forse è stato un passaggio successivo rispetto al mondo della narrazione, anche perchè le mie architetture narrative sono spesso cadenzate dalla sinestesia: la contaminazione dei sensi nella percezione ritengo che sia fondamentale per creare quel collegamento spirituale empatico tra autore e lettore, che lo seduce nell’altrove letterario in cui lo devi catapultare”.
Cosa ti ha spinto a scrivere questo romanzo, che all’apparenza sembra così lontano da noi?
“Il fine è che la memoria è l’antidoto all’indifferenza e all’oblio. Lo spunto restano i Mondiali di calcio del 1978, dove quella gioia contagiosa in realtà nascondeva l’orrore delle torture da parte del governo argentino. Ero un bambino ma mi alzavo di notte per vedere le partite degli azzurri di Bearzot, poi ecco che a distanza di anni hai la percezione che il grande inganno ordito si è tramutato in tragica realtà: le Ford Falcon che ringhiano sull’asfalto, l’arroganza delle patotas, i bambini sottratti alle famiglie, le torture imposte dal governo, i desaparecidos, i girotondi strazianti delle Madres e delle Abuelas attorno all’Obelisco di plaza de Mayo, i voli della morte… sono diventati nel tempo dei frammenti che si sono accavallati fino a creare un film completo. E intanto la gente si riversava in strada cantando la propria felicità, illusa che la vittoria nel calcio rappresentasse la gioia suprema, invece aveva partecipato a quella pantomima della banalità del male. Allora, come scrittore ti poni delle problematiche, provi a superare quei conflitti irrisolti, sempre attuali, che covi dentro come metastasi da far fuoriuscire. Si muovono dentro finché, almeno nella fiction, cerchi la pace e le getti in pasto al lettore, permettendogli di creare una sua idea e, quindi, una sua coscienza”.
Nel tuo romanzo siamo a Buenos Aires, durante la farsa dei Mondiali di Argentina 78, poi veniamo catapultati nel 2018: passato e presente si alternano e si accavallano. Se durante la feroce dittatura militare di Videla scomparivano gli oppositori ecco che a distanza di 40 anni a sparire sono i nipoti appena adolescenti degli appartenenti a quel regime. Il richiamo alla legge del contrappasso è immediata.
“Oggi le Madres e le Abuelas di plaza de Mayo non provano odio ma urlano il Nunca Màs, tese alla ricerca della verità, il sapere che fine hanno fatto i loro figli che 40 anni fa sono desaparecidos in nome di uno Stato che divorava i suoi stessi figli anteponendo Dio, patria e famiglia. A distanza di 40 anni a sparire stavolta sono i figli degli aguzzini, in un lento e tragico capovolgimento dei ruoli tra vittime e carnefici, ma come insegna la vita alla fine nulla è scontato e tutti sono colpevoli e nessuno mai del tutto innocente. Il personaggio principale, il detective Josè Cavalcanti, di chiara origine italiana, è teso alla ricerca ontologica, oggettiva ma anche personale, perché ognuno di noi deve sapere scrutare dentro di sé, come sempre mosso da un demone socratico. E lì le piccole storie ci insegnano che la memoria deve contrastare non solo l’oblio ma anche l’ipocrisia, che va estirpata da una società gretta e superficiale come quella di oggi, che si ferma alle apparenze”.
Josè Cavalcanti si muove a tempo di musica nella sua indagine?
“Si muove lasciandosi avvolgere dalla musica, dai profumi, dai colori di Buenos Aires e da quella dei suoi abitanti. Anche lui è soggetto a quello che in psicologia è chiamato effetto alone, la tiene bene impressa: niente appare come sembra in superficie. È una sua regola di vita, sebbene poi anche lui abbassa le sue immunità e viene permeato dal Male che combatte. Lì vacillano le sue sicurezze di uomo già colmo di dubbi e fragilità. Certo, poi torna nella sua comfort zone, la sua alcova di gourmet e ascolta musica di Astor Piazzolla e, chissà, forse anche di Marco Lo Russo”.
E il tuo personale demone socratico da cosa è mosso?
“Uno scrittore non smette mai di placare il suo senso dell’inquietudine, o il suo stato del desiderio se non fosse tormentato o angosciato. Non è detto che per produrre letteratura un artista debba essere agitato, può anche condividere la serenità e la felicità, è da lì che parte la ricerca di un desiderio maggiore, proprio senza dimenticare la sofferenza, perché quella va coltivata dentro di noi con le cicatrici che gettano pus e sangue. La tragedia greca in questo ci insegna moltissimo, produzione che tutti gli autori devono tenere conto”.